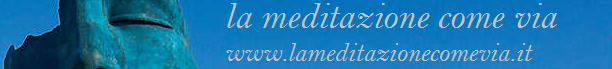|
|
|
| Vita |
| Pubblicazioni |
| Prossimi eventi |
|
|
| Filosofia antica | |
| Mistica | |
| Sufismo | |
| Taoismo | |
| Vedanta | |
| Buddhismo | |
| Zen | |
| Filosofia Comparata | |
| Musica / Mistica | |
| Filosofia Critica | |
| Meditazione | |
| Alchimia | |
| Psiché | |
| Tantrismo | |
| Varia | |
|
| Mircea Eliade |
| Raimon Panikkar |
| S.Weil e C.Campo |
| René Guénon, ecc. |
| Elémire Zolla |
| G.I.Gurdjieff |
| Jiddu Krishnamurti |
| Rudolf Steiner |
| P. C. Bori |
| Silvano Agosti |
| Alcuni maestri |
Il Sufismo in Italia - Innamorati figli di
Allah
(Alessandra Garusi)
Nel
nostro Paese sono poco più di un migliaio. Eppure i sufi della confraternita
Jerrahi-Halveti hanno una influenza non piccola nel mondo islamico: colti,
creativi e mistici, incarnano il rifiuto del dogmatismo nella ricerca del
divino.
«Ci sono mille modi di inginocchiarsi e di baciare la terra», scrive il più grande dei poeti sufi Gialal al-Din Rumi, nato in quel che oggi è l’Afghanistan nel 1207. «Di là dalle idee, di là da ciò che è giusto e ingiusto, c’è un luogo. Incontriamoci là». E questo "là" può essere ovunque: da un loft di New York a una moschea di Istànbul.
Nel caso della confraternita musulmana (tarîqa) dei sufi Jerrahi-Halveti in Italia – che conta 1.086 membri – la dergah ("casa madre") ha sede a Milano, in viale Piceno 23/a. Un seminterrato di questo stabile grande e anonimo ospita ogni primo e terzo mercoledì del mese la piccola comunità – sotto la guida del khalyfa ("vicario generale") Gabriele Mandel Khân – per il dhikr collettivo (la "rammemorazione" di Dio).

Fakhraddin Gafarov
intona una poesia in lingua turca.
È la cerimonia principale dei sufi – i mistici dell’islam – durante la quale si leggono poesie in lingua turca e versetti coranici, al ritmo di una musica il cui crescendo accompagna "l’ascesi" (âl Zohd). «Qui accenniamo solo a una danza, alzandoci in piedi e cantando con un certo movimento della mano "Allah, Allah"», spiega Mandel, «perché il poco spazio non permette di più. Ma quando siamo tre o quattro volte i presenti di oggi (una trentina), andiamo nella moschea di via Padova 144. E allora sì che si può davvero danzare».
A Istànbul – dove è sepolto il fondatore di questa confraternita, Pîr Nurettin-Jerrahi – si ruota anche per tre ore sui propri piedi in un rito che è simbolo della vita. Perché ruotare è la condizione fondamentale dell’esistenza: nell’atomo ruotano gli elettroni e i neutroni; nel cosmo ruotano i pianeti e le stelle; e anche gli uomini ruotano sulla terra poiché provengono dalla polvere e alla polvere ritornano.

Al suono del tamburo,
conduce il rito seguito dai fedeli presenti.
A Milano, tutto è in scala ridotta: il dhikr cade ogni 15 e non ogni sette giorni; dura una o due ore iniziando alle 18, anziché alle 20, per permettere a tutti di arrivare. Andrea Raggi, ad esempio, è uno scultore di Forlì. Dal 2000 a oggi – cioè da quando è diventato musulmano e sufi («si è sufi solo se si è musulmani») – viene sempre. Viaggia in auto con la moglie – pure lei aderente alla confraternita – e ci mette cinque ore. E, come loro, c’è chi arriva da Torino, Genova, ecc. E chi ancora da più lontano.
Fakhraddin Gafarov, 41 anni, è di origine azera, ma oggi vive e lavora a Milano. È un musicista professionista: viene considerato uno dei maggiori suonatori di târ del mondo islamico. A Baku, fra il 1994 e il 1998, ha diretto il conservatorio nazionale di musica. Arrestato nel 1998 per aver istituito un «comitato di difesa dei valori tradizionali della cultura azera», ha ottenuto lo status di rifugiato politico prima in Germania e poi in Italia.

Il dhikr collettivo (la
"rammemorazione" di Dio), guidato
dal khalyfa Gabriele Mandel Khân, nella comunità milanese.
Quest’uomo dall’aria affabile e i baffi scuri è seduto alla sinistra del khalyfa e guida la cerimonia, suonando un tamburo e cantando in turco. Ruolo, questo, che ricopre anche negli altri centri della stessa confraternita sufi (tekké) sparsi per l’Italia: cioè Bari, Biella, Genova, Padova, Portico di Romagna, Roma, Torino. A proposito del dhikr, il musicista dice: «Mi avvicina a Dio, mi aiuta a vivere. E alla fine prendo molto di più di quel che do. Energia».
«Già, che cosa ci facciamo qui?», interviene Nurettin Venturi, lo shaykh (maestro) della tekké di Genova. «Si tratta di sentire la fede con tutto il corpo, e non solo col cervello, o da un punto di vista meramente rituale», risponde questo professore di Storia delle religioni, che sin da ragazzino – da quando aveva appena 16 anni – s’interessa al sufismo. Lo chiamano "il filosofo".

Il dhikr collettivo (la
"rammemorazione" di Dio), guidato
dal khalyfa Gabriele Mandel Khân, nella comunità milanese.
Ecco il primo fondamentale distinguo - «Vi sono dei religiosi nell’islam che impongono un dogma: è solo una scorza esterna senza alcun valore. E, come una noce di cocco vuota, più viene agitata e più fa rumore», spiega il khalyfa. «Costoro chiedono un’osservanza delle regole e dei riti, senza alcun contenuto o afflato spirituale. Ora, i sufi sono esattamente il contrario: vogliono penetrare i valori; e quasi quasi, delle regole esterne non se ne fanno nulla. Loro vogliono arrivare il più possibile vicino alla comprensione di Dio».
«Tutto sulla terra è nulla», dice il Corano. E allora il sufi è «nel mondo, ma non del mondo». Vive una vita comune, soffre, lavora, paga le tasse, ha il passaporto e soprattutto viaggia moltissimo: con il corpo e con la mente, nei secoli e nei libri, nelle opere d’arte di chi ci ha preceduto. Tuttavia non è conquistato dalle vanità mondane, non è stato preso al laccio da sistemi di governo, o politici, o finanziari, o consumistici, non è limitato da concetti di patria o da confini, da colori della pelle o diatribe etniche. «Tutto si risolve in un continuo di energia, tutto è una nebbia, qua e là più densa o meno densa. E noi siamo energia, nebbia, come qualsiasi cosa di questo mondo terreno, ma possediamo un’anima divina, goccia di quell’oceano senza fine che è Dio, e il nostro fine ultimo è Dio», scrive Mandel nel suo libro La via al Sufismo (Ed. Bompiani).

Il dhikr collettivo (la
"rammemorazione" di Dio), guidato dal khalyfa Gabriele Mandel Khân (al centro
qui sopra), nella comunità milanese.
Ora sono da poco passate le sei del pomeriggio. L’intera comunità – suddivisa in apprendisti (i sufi che hanno ricevuto l’iniziazione), compagni (i sufi che hanno ricevuto gradi in seno alla tekké), e i maestri (i capi delle tekké)– si è riunita. E quindi la porta della dergah può essere chiusa. Gli ultimi ritardatari salutano i presenti.
Per ogni tekké la regola turca è questa: quando entrano un khalyfa o maestri di altre dergah o di altre confraternite ci si alza e si dà il benvenuto portando le mani al petto; quando entra il khalyfa lo si saluta in modo speciale (braccia incrociate, inchino e alluce destro su alluce sinistro); ai maestri, invece, normalmente si bacia la mano e quando un maestro dà a un sufi qualcosa, il sufi bacia ciò che riceve.
Il tempo dei convenevoli si è dunque appena concluso. Nel piccolo corridoio senza finestre resta una ragazzina che aspetterà, per l’intera durata della cerimonia, il proprio padre. Tutti gli altri membri della comunità si siedono a terra in cerchio: gli uomini con lo zucchetto bianco in testa formano quello più stretto, davanti, e le donne velate stanno verso la parte esterna, dietro. Queste ultime, nelle moschee di Istànbul, si affacciano invece dall’alto dei matronei. Il khalyfa si accomoda quindi su una pelle d’animale. Pelle che lo rappresenta quando è assente e che non può mai essere calpestata. E il dhikr può finalmente cominciare. Le luci sono state spente.

Il dhikr collettivo (la
"rammemorazione" di Dio), guidato
dal khalyfa Gabriele Mandel Khân, nella comunità milanese.
Sul tappeto, davanti alle ginocchia del cerchio più stretto – quello degli uomini – è stato steso un rosario musulmano. Si chiama subha in arabo, e tashbì (o anche komboloy) in turco. Ha 99 grani (o 33 ripetuti tre volte), tanti quanti sono i nomi di Dio nel Corano. E, del resto, la cerimonia inizialmente consiste proprio in questo: nella ripetizione di uno o più nomi di Dio. Ecco perché il rosario è così importante: simboleggia quel che si farà prima solo con la lingua, poi anche con il cuore.
Il maestro Âhmad Nûrî Così, piano piano, espresse con queste parole la propria ansia mistica emergente dal dhikr: «Vorrei rammemorarLo senza sosta, tanto il mio amore per Lui è intenso, ma, cosa stupefacente, la rammemorazione rapisce nell’estasi (wajd); ma, cosa ancor più stupefacente: a volte è l’estasi che sparisce, a volte è la rammemorazione stessa, nella prossimità e nella lontananza».

Il dhikr collettivo (la
"rammemorazione" di Dio), guidato
dal khalyfa Gabriele Mandel Khân, nella comunità milanese.
Il silenzio è rotto dal suono del tamburo e dalla voce del musicista azero che canta in lingua turca. Quel suono è nitido, dura a lungo. E, se lo si ascolta a occhi chiusi, apre l’occhio della comprensione extramateriale. Occorre una materia (appunto, uno strumento a percussione), ma da questa materia emerge una vibrazione che non è visibile né afferrabile con le mani. Non se ne vede né il colore né il peso. «La coordinazione del suono grazie al ritmo e alla simmetria dà un’arte sublime, la musica, che non ha bisogno di traduzione né di parole per comunicare», dice Mandel.
Mentre il ritmo della musica si fa sempre più serrato, cambia anche quello del respiro dei presenti: inspirazione ed espirazione sono velocissime, secche e potenti. Secondo gli psicologi e i neurologi, è proprio questa iperventilazione dei ventricoli cerebrali e quindi questa iperossigenazione del sistema nervoso centrale a produrre una serie di effetti particolari: le illuminazioni che si hanno durante il rito, la presenza sensibile del divino, la "compagnia" avvertibile ma spesso anche udibile di entità superiori.

Immagini del dhikr
collettivo nella fase centrale: i fedeli presenti
hanno gli occhi chiusi e si lasciano guidare dalla musica,
il cui crescendo accompagna "l’ascesi" (âl Zohd).
«Ventiquattro anni fa, quando cambiai confraternita e fui iniziato alla Jerrahi-Halveti (o Jerrahiyya-Khalwatiyya: uno dei più antichi ordini tradizionali sufi), durante quel dhikr in una moschea di Istànbul, vidi mio padre che era morto già da dieci anni. Parlai con lui una quindicina di minuti», ci racconta Mandel. «Da allora, quando voglio vederlo, lo "chiamo" e lui viene». Allo stesso modo, durante questo dhikr, ci sono forti reazioni emotive: uno scoppia in un pianto che sembra disperato; e, per l’intera durata della cerimonia, le sue spalle saranno scosse dai singhiozzi. Poi si calma.
Gli occhi di tutti si riaprono su quella stanza. E il khalyfa prende la parola. Quest’uomo – che è stato co-fondatore dell’Università islamica di Ibn Roshd di Cordoba (Spagna) ed è direttore della facoltà di Psicologia dell’Università europea di Bruxelles, oltre a essere «il più importante ceramista islamico contemporaneo» (secondo lo European Who’s Who del 1988) – ha un’enorme autorevolezza. Malgrado abbia oltrepassato i 90 anni, conserva la carica energetica di un ragazzino. Dunque quando parla, c’è un silenzio assoluto.

Immagini del dhikr
collettivo nella fase centrale: i fedeli presenti
hanno gli occhi chiusi e si lasciano guidare dalla musica,
il cui crescendo accompagna "l’ascesi" (âl Zohd).
Uno a uno, Mandel interpella tutti sul «come è andata». Lo scultore in pietra: «È sempre una grande gioia essere qui». Il professore di Storia delle religioni: «Tutto è dato». Il libero professionista milanese: «Io ho solo colpe, quindi passo volentieri la mano»; secca la replica del khalyfa: «Non s’illuda, si rimetta a Lui». Il fabbricante di violini: «Magnifico». La psicanalista: «Grazie». L’infettivologo e psicoterapeuta che nella vita professionale si occupa di sieropositivi: «Ho visto l’immagine di un grande albero; lo scienziato prende una foglia per studiarla, ma gli sfugge il fatto che la linfa vitale arriva dalle radici, da Dio».
Chi conosce, anche solo per sentito dire il sufismo, non si sorprende dell’alto grado di cultura che caratterizza i membri delle confraternite. A questo proposito Sayed Husein Nasr ha scritto: «Come il respiro che anima il corpo, il sufismo ha infuso il suo spirito in tutta la struttura dell’islam, sia nelle manifestazioni sociali, sia in quelle intellettuali».

Immagini del dhikr
collettivo nella fase centrale: i fedeli presenti
hanno gli occhi chiusi e si lasciano guidare dalla musica,
il cui crescendo accompagna "l’ascesi" (âl Zohd).
La diretta partecipazione di molti sufi alla fondazione di università – ad esempio quella di âl Âzhar al Cairo, in Egitto, aperta nel 983 e attiva ancor oggi – come pure il ruolo svolto da centri sufi nella diffusione dell’istruzione, rendono il suo influsso inseparabile dallo sviluppo culturale dell’islam. Aggiunge Mandel: «Quando, durante certi periodi, in alcune regioni il sistema educativo tradizionale fu distrutto, i centri sufi rimasero gli unici depositari del sapere ufficiale e accademico e, sulla base delle loro conoscenze, si poterono ricostruire le scuole tradizionali».
Ma è nel settore delle scienze e delle arti – dall’architettura alla calligrafia, alla poesia – che l’influsso del sufismo fu davvero determinante. Insomma, i sufi sono «la gente del sapere sapienziale» e «della visione» (dhawq). E lo sono perché l’arte è un privilegio che avvicina a Dio.

Immagini del dhikr
collettivo nella fase centrale: i fedeli presenti
hanno gli occhi chiusi e si lasciano guidare dalla musica,
il cui crescendo accompagna "l’ascesi" (âl Zohd).
«Pensi solo a come la musica ci fa sentire l’afflato divino», mi dice ancora il khalyfa. «Se la religione "predica" la pace, l’arte "è" pace. Tanto è vero che il maggior nemico dell’arte è la guerra, che distrugge le opere d’arte». Di conseguenza i sufi, essendo amanti dell’arte o addirittura creatori di opere d’arte, sono contrari alla guerra e lo dicono apertamente. E non si stancano di ripetere uno dei più bei detti del Profeta: «Înna Âllâh jamîl, îuhibbu âlJamâl»: «Certo, Dio è bello e ama la bellezza».
Da: http://www.stpauls.it/jesus/0506je/0506je50.htm