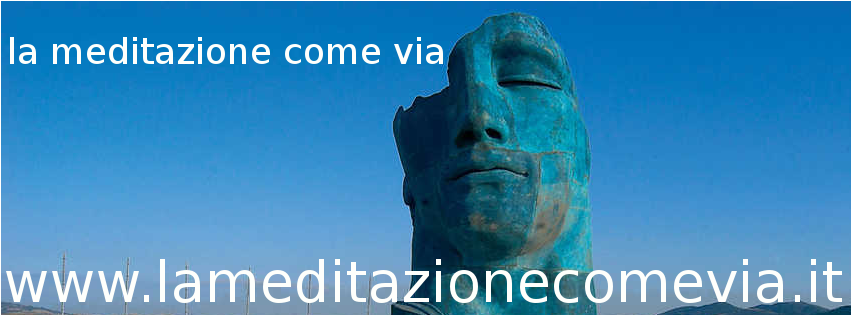|
|
|
| Vita |
| Pubblicazioni |
| Prossimi eventi |
|
| Mircea Eliade |
| Raimon Panikkar |
| S.Weil e C.Campo |
| René Guénon, ecc. |
| Elémire Zolla |
| G.I.Gurdjieff |
| Jiddu Krishnamurti |
| Nietzsche |
| Rudolf Steiner |
| P. C. Bori |
| Silvano Agosti |
| Alcuni maestri |
Marco Passavanti, Alcune
considerazioni sull'origine degli āsana dello yoga moderno
L’origine storica della pratica delle posizioni (āsana) è ormai una questione ampiamente dibattuta tra i cultori dello yoga, sia praticanti sia studiosi. Le opinioni al riguardo sono varie e contraddittorie: alcuni (in numero sempre minore) propendono per una remotissima antichità, che risalirebbe all’epoca vedica o ai secoli successivi, spesso attribuendone l’origine a Patañjali stesso.
Altri, in numero sempre crescente, hanno iniziato a mettere in discussione
questa narrazione, spesso portata avanti da maestri o insegnanti che si rifanno
a una qualche forma di ‘autorità’, a un guru o a un testo tradizionale.
Soprattutto grazie alle ricerche provenienti dal mondo accademico, si è
cominciato a discutere la questione da un punto di vista rigorosamente storico:
Quali sono i testi in cui si inizia a parlare delle posizioni?
A quale epoca risalgono?
Quali erano le pratiche degli yogin di mille anni fa?
Assomigliavano a quelle degli yogin di oggi?
Che ruolo ha avuto il processo di trasmissione dello yoga in Occidente nei suoi
sviluppi più recenti?
La risposta a queste e a tante altre domande ha fatto emergere un quadro assi più complesso di quello che credevamo.
Alcuni studi pionieristici sull’argomento hanno indagato i rapporti tra elementi tradizionali indiani e istanze provenienti dall’Occidente nella formazione di quello che chiamiamo ‘yoga moderno’ (modern yoga).
Mark Singleton (2010), nel suo saggio intitolato Yoga Body, The Origins of Modern Posture Practice, ha indagato il rapporto tra lo yoga fisico praticato nell’India coloniale e le forme di ginnastica calistenica o di cultura fisica in voga in Europa e in America durante il XIX e il XX secolo. Il quadro che ne emerge chiama in causa una delle figure emblematiche dello yoga moderno: Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989).
Nato in una famiglia brahmanica di tradizione Śrīvaisnava, negli anni della giovinezza seguì un vasto curriculum di studi, che culminarono in diversi anni di apprendistato presso un misterioso yogin himalayano. Al termine di questi anni, ritornato alla vita di capofamiglia, si dedicò all’insegnamento dello yoga, avendo come discepoli figure come BKS Iyengar, Pattabhi Jois e Desikachar. Il suo stile di pratica dell’Hathayoga, che dava grande risalto agli āsana, è alla base di quasi tutte le forme di yoga posturale oggi in voga.
La tesi controversa proposta nello studio di Singleton è che molte delle posizioni da lui proposte fossero il prodotto di un incontro e di una fusione con altre tradizioni di cultura fisica (soprattutto la ginnastica in voga nel Nord Europa). In questo incontro avrebbe giocato un ruolo fondamentale la volontà da parte di Krishnamacharya di creare una forma squisitamente indiana di cultura fisica, ovvero una ginnastica ‘tradizionale’ da contrapporre orgogliosamente agli sport e alle forme di esercizio fisico importate dall’Occidente. Secondo questo studio, molte forme di yoga fisico diffuse oggi in Occidente sarebbero dunque uno sviluppo moderno di forme tradizionali di yoga, e non potrebbero vantare quella antichità che molti loro cultori gli attribuiscono.

Le reazioni a questa teoria non sono mancate: per molte scuole moderne di yoga, legate all’autorità di un maestro e di un lignaggio, è fondamentale mantenere un forte legame con la tradizione, spesso attribuendo all’autorità di un mitico fondatore o a un maestro del passato la paternità di testi e pratiche. Figure come Patañjali, Nāthamuni, Yājñavalkya, Matsyendra (e oggi Krishnamacharya stesso) sono viste da molte tradizioni moderne come i ‘padri fondatori’ dello yoga, il cui insegnamento sarebbe giunto puro e incontaminato fino a noi. L’antichità di certe pratiche è data dunque per scontata, pena la perdita di legittimità dell’intero sistema.
Non devono dunque stupire certe derive che si riscontrano oggi nello yoga globalizzato, pensiamo, ad esempio, a un insegnante di fama mondiale come Bikram Choudury, che sostiene (contro ogni evidenza oggettiva) che il proprio sistema di pratica risalga a Patañjali stesso. Oggi in Occidente possedere uno yoga ‘tradizionale’ permette di vendere un prodotto ritenuto ‘autentico’, e poco importa che lo sia davvero, perché ciò che conta è che il vasto pubblico creda che lo sia.
Una tesi opposta a quella di Singleton è quella avanzata (con molti punti dubbi) da Christopher Tompkins ( http://www.sutrajournal.com/christopher-tompkins-on-the-origins-of-vinyasa ), che sostiene di aver trovato le prove della remota origine della pratica dei vinyāsa in diversi testi tantrici. Sfortunatamente Tompkins, a quanto ne so, non ha pubblicato nessun articolo scientifico sull’argomento, ma si limita a offrire dei corsi online a pagamento.
La sua tesi è stata sposata, guarda caso, da una vera valchiria dello yoga business come Shiva Rea (http://samudraglobalyoga.com/history-of-yoga.html). Il sodalizio tra i due è emblematico della ricerca di legittimazione di molti yogin contemporanei: poter vantare una remota origine ‘tantrica’ delle moderne forme di Vinyasa Flow fa vendere, e dà una patente di legittimità e di antichità al proprio prodotto.
Di recente sono emersi nel mondo accademico nuovi punti di vista, che mettono in parte in discussione l’origine moderna dello yoga posturale. Benché resti indubbio che la pratica degli āsanacome la conosciamo oggi sia il risultato di un processo di trasformazione profonda di forme tradizionali, iniziano a emergere dati storici che mostrano una genesi molto più complessa di quella proposta da Singleton.
Gruppi di studiosi (come ad esempio l’ Hathayoga project: http://hyp.soas.ac.uk/) stanno iniziando a studiare e a pubblicare nuovo materiale sull’argomento, destinato sicuramente a mutare la nostra prospettiva. I campi da indagare sono molti, e richiederebbero di ampliare la ricerca anche al di fuori dall’ambito strettamente indiano: le antiche forme di yoga fisico tibetane (note come yantra yoga o ‘phrul ‘khor), le pratiche dei Sufi persiani, l’alchimia indiana, le tradizioni ginniche e marziali cinesi (alcune delle quali rivendicano un’origine indiana) rivelano tutti rapporti complessi e spesso remoti con le tradizioni yogiche indiane.

Cosa rispondere a chi ci chiede quanto è antico lo yoga che pratichiamo?
Lo yoga di oggi, che prevede il più delle volte l’esecuzione di posizioni, è il frutto di un processo di evoluzione storica: dall’incontro (e dallo scontro) tra due culture millenarie, quella dell’India e quella dell’Occidente, è nata una pratica che da elitaria quale è sempre stata è divenuta fenomeno di massa, soggetta alle leggi del mercato e della comunicazione.
Il processo di passaggio dello yoga dall’India all’Occidente è stato dunque un processo di traduzione, e la pratica fisica ne rappresenta forse l’emblema. La traduzione non può, e forse non deve, essere letterale. Lo yoga ha sempre avuto una grandissima capacità di adattamento (favorita dall’ampiezza semantica del termine stesso ‘yoga’) ed è proprio grazie ad essa che è riuscito ad attraversare i secoli: in altre parole, lo yoga giunto in Occidente ha dovuto cambiare forma e adattarsi per attecchire.
È un processo del tutto naturale e legittimo, a patto che si rinunci all’idea di uno yoga ‘eterno’, ‘immutabile’, ‘primordiale’, ‘puro’ e completamente ‘tradizionale’, uno yoga che non è mai esistito, se non nelle narrazioni di molti guru e di molti loro discepoli occidentali.
Ma mutare non significa necessariamente tradire il passato: ancora oggi si ricorre a tecniche le cui origini risalgono indubbiamente a secoli o a millenni fa. Illudersi di praticare lo stesso yoga di uno yogin kashmiro di mille anni fa o di un nāth del XVI secolo è palesemente insostenibile. Ma richiamarsi all’autorità di tradizioni che vantano lignaggi vecchi di secoli non è affatto un errore o un’illusione, e costituisce per molti un importante elemento della pratica. Il contatto con la storia e con la tradizione può contribuire a dare un senso a ciò che si fa, e può dare accesso a un immaginario simbolico fondamentale da cui trarre suggestioni e ispirazione.
Non sottolineerò mai abbastanza come lo yoga sia certo pratica ma sia anche studio, e come questo studio sia un elemento imprescindibile del mestiere di insegnante, ovvero di colui che traduce e diffonde lo yoga oggi: sforzarsi di conoscere la storia di ciò che si insegna, comprenderne il contesto culturale e la letteratura, non è una semplice curiosità intellettuale, ma è uno dei requisiti fondamentali di un insegnante.
Essere oggi un insegnante di yoga non significa necessariamente ‘giocare a fare l’indiano’ (anche se certe goffe ingenuità farebbero a volte pensare il contrario), ma significa mediare tra una cultura e un’altra per provare a creare e condividere un orizzonte di senso.
Da: http://www.viniyogaitalia.it