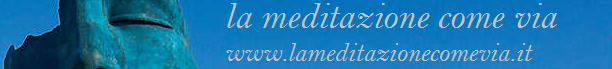|
|
|
| Vita |
| Pubblicazioni |
| Prossimi eventi |
|
|
| Filosofia antica | |
| Mistica | |
| Sufismo | |
| Taoismo | |
| Vedanta | |
| Buddhismo | |
| Zen | |
| Filosofia Comparata | |
| Musica / Mistica | |
| Filosofia Critica | |
| Meditazione | |
| Alchimia | |
| Psiché | |
| Tantrismo | |
| Varia | |
|
| Mircea Eliade |
| Raimon Panikkar |
| S.Weil e C.Campo |
| René Guénon, ecc. |
| Elémire Zolla |
| G.I.Gurdjieff |
| Jiddu Krishnamurti |
| Rudolf Steiner |
| P. C. Bori |
| Silvano Agosti |
| Alcuni maestri |
La Scuola di Francoforte: Horkheimer e
Adorno
(Giuseppe Bedeschi)
-
- La scuola di
Francoforte è costituita da un gruppo di studiosi riunito intorno al celebre
Istituto per la Ricerca Sociale. Professor Bedeschi incominciamo proprio dalla
denominazione: perché "scuola di Francoforte"?
(1)
-
- Horkheimer assume la
direzione della scuola di Francoforte nel 1929: Professor Bedeschi quali sono
i tratti salienti della personalità di questo filosofo?
(2)
-
- In che senso al centro
della riflessione di Horkheimer c'è la rivendicazione del valore della
dialettica marxistica, che poi è una delle caratteristiche più importanti
dell'intera scuola di Francoforte?
(3)
-
- A differenza di quanto
sosteneva il marxismo classico per il quale la scienza era uno strumento
neutrale rispetto a proletariato e borghesia, per Horkheimer la scienza
comporta inevitabilmente anche un dominio dell'uomo sull'uomo. Professore,
vorrei che discutesse proprio questo tema, ovvero il legame tra scienza e
capitalismo.
(4)
- - Professor Bedeschi, Horkheimer, oltre a interessi filosofici e sociologici, aveva anche interesse nei confronti della psicologia del profondo e della psicoanalisi. Questo interesse rappresenta un altro aspetto essenziale della proposta culturale della scuola di Francoforte in generale: il tentativo di rettificare, integrare il marxismo con la psicoanalisi . (5)
- - Altri esponenti della scuola di Francoforte, oltre Horkheimer, si impegnarono nel tentativo di utilizzare la psicoanalisi ai fini dell'indagine sociale, in primo luogo ad Erich Fromm. Pensa che il tentativo di Fromm di coniugare psicologia del profondo e marxismo, abbia avuto più successo? (6)
- - Professor Bedeschi, qual è stato il contributo di Theodor Wiesengrund Adorno alla ricerca della scuola di Francoforte? (7)
- - Quali sono i temi fondamentali della Dialettica dell'Illuminismo? (8)
- - Professor Bedeschi, buona parte dell'opera di Adorno è dedicata all'analisi critica della "industria culturale"; questa è una categoria divenuta famosa a partire dagli anni '60, quando esplose un particolare interesse per la scuola di Francoforte. Quali sono allora i temi principali di questa critica che Adorno rivolge all'"industria culturale"? (9)
1. La scuola di Francoforte è costituita da un gruppo di studiosi riunito intorno al celebre "Istituto per la Ricerca Sociale". Professor Bedeschi incominciamo proprio dalla denominazione: perché "scuola di Francoforte"?
Bisogna risalire, come Lei ha detto, all'Istituto per la Ricerca Sociale (Istitut für Sozialforschung) che fu fondato a Francoforte nel 1922 da un gruppo di intellettuali marxisti indipendenti. L'Istituto per la Ricerca Sociale era sorto in modo autonomo dal punto di vista finanziario, perché aveva avuto una generosa donazione privata; in seguito l'Istituto fece domanda, che fu accolta, per essere affiliato alla Università di Francoforte; la clausola posta dal Ministero della Istruzione prevedeva che il direttore dell'Istituto fosse un professore d'Università. Con questo riconoscimento accademico l'Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte divenne il primo Istituto accademico tedesco interamente composto da intellettuali marxisti. Il primo direttore dell'Istituto fu un economista, Kurt Albert Gerlach, che però morì precocemente pochi mesi dopo la sua nomina. Gli successe Karl Grünberg, che era stato professore di Scienza politica all'Università di Vienna e che aveva fondato una rivista assai importante nel 1910, l'"Archivio per la storia della socialismo e del movimento operaio", al quale collaboravano eminenti pensatori come György Lukács e Karl Korsch. Con la direzione di Grünberg questa rivista divenne l'organo scientifico dell'Istituto; ad essa, così come allo stesso Istituto, collaborava un folto gruppo di intellettuali destinati ad esercitare un influsso profondo su alcuni filoni del pensiero occidentale. I nomi più noti sono quelli di Max Horkheimer, di Friedrich Pollock, di Karl August Wittfogel, di Franz Borkenau, di Henryk Grossmann e, verso la fine degli anni '20, di Leo Löwenthal e di Theodor Wiesengrund Adorno. Più tardi, agli inizi degli anni '30 entrarono a far parte dell'Istituto Herbert Marcuse ed Erich Fromm.
Fu comunque nel 1929 che avvenne il vero e proprio salto di qualità nella vita dell'Istituto per la Ricerca Sociale; Grünberg infatti nel '29 si dimise dalla carica di direttore dell'Istituto per motivi di salute e gli successe Max Horkheimer. Fu sotto la direzione di Horkheimer che l'Istituto conobbe la sua migliore stagione, sviluppò quelle tematiche e assunse quelle caratteristiche culturali che identificano la scuola di Francoforte.
2. Horkheimer assume la direzione della scuola di Francoforte nel 1929: Professor Bedeschi quali sono i tratti salienti della personalità di questo filosofo?
 La
personalità di Horkheimer è una personalità molto complessa come quasi tutte le
personalità degli studiosi della scuola di Francoforte. È difficile racchiuderla
in una formula o catalogarla sotto una etichetta. Era nato nel 1895 a Stoccarda
da agiata famiglia, si era laureato in filosofia con una tesi su Kant; un
particolare significativo da tenere presente è il fatto che avesse seguito anche
dei corsi di psicologia, in particolare di psicologia della Gestalt. È un dato
rilevante perché la psicologia occuperà sempre un posto importante negli
interessi intellettuali di Horkheimer, il quale era un intellettuale marxista,
ma indipendente; non militava in alcun partito e le sue simpatie
ideologico-politiche erano andate negli anni giovanili a Rosa Luxemburg.
Horkheimer sul piano politico aveva una posizione di eguale distanza dai
comunisti e dai socialdemocratici: ai comunisti rimproverava di avere ridotto il
marxismo a una serie di formule morte, a un morto catechismo, mentre ai
socialdemocratici rimproverava di avere abbandonato il marxismo rivoluzionario e
di essersi conformati alla realtà esistente. Agli uni e agli altri, ai comunisti
e alla cultura comunista, ai socialdemocratici e alla cultura socialdemocratica,
Horkheimer contrapponeva un marxismo incentrato sulla dialettica.
La
personalità di Horkheimer è una personalità molto complessa come quasi tutte le
personalità degli studiosi della scuola di Francoforte. È difficile racchiuderla
in una formula o catalogarla sotto una etichetta. Era nato nel 1895 a Stoccarda
da agiata famiglia, si era laureato in filosofia con una tesi su Kant; un
particolare significativo da tenere presente è il fatto che avesse seguito anche
dei corsi di psicologia, in particolare di psicologia della Gestalt. È un dato
rilevante perché la psicologia occuperà sempre un posto importante negli
interessi intellettuali di Horkheimer, il quale era un intellettuale marxista,
ma indipendente; non militava in alcun partito e le sue simpatie
ideologico-politiche erano andate negli anni giovanili a Rosa Luxemburg.
Horkheimer sul piano politico aveva una posizione di eguale distanza dai
comunisti e dai socialdemocratici: ai comunisti rimproverava di avere ridotto il
marxismo a una serie di formule morte, a un morto catechismo, mentre ai
socialdemocratici rimproverava di avere abbandonato il marxismo rivoluzionario e
di essersi conformati alla realtà esistente. Agli uni e agli altri, ai comunisti
e alla cultura comunista, ai socialdemocratici e alla cultura socialdemocratica,
Horkheimer contrapponeva un marxismo incentrato sulla dialettica.
3. In che senso al centro della riflessione di Horkheimer c'è la rivendicazione del valore della dialettica marxistica, che poi è una delle caratteristiche più importanti dell'intera scuola di Francoforte?
Certamente la concezione dialettica del marxismo, che è senza dubbio mutuata dalla dottrina di Hegel, è una caratteristica fondamentale degli esponenti della scuola di Francoforte. Al riguardo Horkheimer in primo luogo, ma poi anche gli altri, Adorno, Marcuse e così via, subivano l'influsso di György Lukács e di Karl Korsch; soprattutto un libro di Lukács del 1923 Storia e coscienza di classe ha esercitato un influsso profondo sul cosiddetto marxismo occidentale. Questa concezione dialettica del marxismo e, più in generale, la concezione delle scienze sociali, implicava un'aspra critica del metodo scientifico cioè del metodo delle scienze naturali o "positive". Alle scienze "positive", alle scienze naturali e al loro metodo veniva rimproverato da Horkheimer in primo luogo di avere un approccio meccanicistico alla realtà, di limitarsi a una registrazione, classificazione e generalizzazione dei fenomeni, di non vedere che la realtà è lacerata da contraddizioni; per questi autori la realtà non è statica bensì dinamica. Può essere utile a questo proposito leggere un passo di Horkheimer tratto da un saggio del 1932, dunque risalente ai primissimi anni della sua direzione dell'Istituto della Ricerca Sociale; egli scriveva: "al metodo orientato sull'essere e non sul divenire, corrispondeva il modo di considerare la forma di società esistente come un meccanismo di processi che si ripetono sempre uguali, che può essere bensì disturbato per un tempo più o meno lungo, ma che comunque non richiede un comportamento scientifico diverso dalla spiegazione di una macchina complicata".
Se si riflette con attenzione su questo passo, su questa affermazione di Horkheimer, si vede che per lui il difetto di fondo del metodo scientifico è quello di non riuscire a concepire la realtà sociale come dialettica, come contraddittoria, come soggetta a gravi convulsioni. Naturalmente bisogna tenere presente un dato di fatto, un riferimento storico molto importante: quando Horkheimer e gli altri suoi collaboratori scrivevano queste cose, la società era in piena crisi economica; questa crisi era cominciata negli Stati Uniti nel 1929 e poi era si era estesa molto rapidamente all'Europa.
4. A differenza di quanto sosteneva il marxismo classico per il quale la scienza era uno strumento neutrale rispetto a proletariato e borghesia, per Horkheimer la scienza comporta inevitabilmente anche un dominio dell'uomo sull'uomo. Professore, vorrei che discutesse proprio questo tema, ovvero il legame tra scienza e capitalismo.
Non c'è dubbio che questo sia un aspetto centrale e decisivo
del pensiero degli esponenti della scuola di Francoforte, di Horkheimer, ma
anche degli altri. C'è in loro la convinzione che il dominio sulla natura, la
trasformazione della natura, comporti necessariamente un dominio dell'uomo
sull'uomo. C'è qui certamente una divaricazione rispetto al pensiero marxiano,
perché Marx aveva sempre pensato che la scienza e la tecnica fossero per un
verso assolutamente indispensabili per il progresso della società umana, e per
un altro verso qualcosa di neutro; c'è un uso capitalistico della scienza e
della tecnica e c'è un loro uso, un'utilizzazione di altro segno, in un'"altra"
società. Su questo punto gli esponenti della scuola di Francoforte e, in  primo
luogo, Horkheimer, che era il loro direttore, seguono invece il punto di vista
di György Lukács, espresso in Storia e coscienza di classe, secondo cui
la scienza non è qualcosa di neutro. I francofortesi radicalizzano questo punto
di vista: non solo la scienza non è qualcosa di neutro, ma è inevitabilmente
"dominio", ed è a tal punto dominio che il tentativo dell'uomo di governare la
natura, di trasformarla ai propri fini, si rovescia necessariamente nel suo
contrario. L'uomo diventa schiavo di poteri, di potenze incontrollabili; alla
luce di questa visione, l'intera civiltà occidentale da Odisseo a Hitler come si
afferma nel libro di Horkheimer e Adorno, Dialettica dell'Illuminismo, è una
storia di regresso, di imbarbarimento.
primo
luogo, Horkheimer, che era il loro direttore, seguono invece il punto di vista
di György Lukács, espresso in Storia e coscienza di classe, secondo cui
la scienza non è qualcosa di neutro. I francofortesi radicalizzano questo punto
di vista: non solo la scienza non è qualcosa di neutro, ma è inevitabilmente
"dominio", ed è a tal punto dominio che il tentativo dell'uomo di governare la
natura, di trasformarla ai propri fini, si rovescia necessariamente nel suo
contrario. L'uomo diventa schiavo di poteri, di potenze incontrollabili; alla
luce di questa visione, l'intera civiltà occidentale da Odisseo a Hitler come si
afferma nel libro di Horkheimer e Adorno, Dialettica dell'Illuminismo, è una
storia di regresso, di imbarbarimento.
Questo naturalmente è un altro tratto che contraddistingue il pensiero dei rappresentanti della scuola di Francoforte dal marxismo classico, perché il marxismo classico ha una concezione ascendente - di tipo hegeliano - della storia del mondo, e quindi ragiona ancora all'interno degli schemi dell'inevitabile progresso della storia dell'umanità. Gli esponenti della scuola di Francoforte abbracciano invece un punto di vista radicalmente diverso, di tipo pessimistico: non credono al progresso, ritengono che il progresso sia un mito e che il lavoro della scienza e della tecnica sia la causa decisiva del degrado e del regresso della civiltà.
5. Professor Bedeschi, Horkheimer, oltre a interessi filosofici e sociologici, aveva anche interesse nei confronti della psicologia del profondo e della psicoanalisi. Questo interesse rappresenta un altro aspetto essenziale della proposta culturale della scuola di Francoforte in generale: il tentativo di rettificare, integrare il marxismo con la psicoanalisi .
Certamente, questo è un altro degli aspetti caratteristici del pensiero della scuola di Francoforte e rappresenta per quei tempi un tentativo, molto generoso e interessante, di coniugare psicoanalisi e marxismo. Naturalmente gli esponenti della scuola trovavano alcune notevoli difficoltà in questa direzione, perché il loro tentativo non poteva non tendere a mettere insieme, a coniugare, a far collaborare categorie e concetti di carattere socio-economico, derivanti dal marxismo, e categorie e concetti, come le pulsioni istintuali, la vita psichica inconscia e così via, che non sono suscettibili di nessuna caratterizzazione in un quadro socio-economico. D'altra parte i limiti del tentativo si vedono molto bene nell'opera di Horkheimer. Per Horkheimer le categorie fondamentali restano quelle socio-economiche: per quale motivo? Perché l'uomo deve in primo luogo produrre e riprodurre le proprie condizioni materiali di esistenza. D'altro canto però la psicologia del profondo, la psicoanalisi in modo particolare, è indispensabile, come scienza sussidiaria, per capire fino in fondo il processo storico, per intendere i grandi fatti storici Non prende a proprio oggetto soltanto i "grandi" individui, gli individui "cosmico-storici", che hanno un ruolo particolare nella storia. Per Horkheimer e per gli altri esponenti della scuola gli individui non sono mere maschere di rapporti economici come più o meno il marxismo precedente aveva asserito. Gli individui si trovano all'interno di determinati rapporti economici, e questi rapporti sono decisivi per la loro vita; essi tuttavia vivono psicologicamente questi rapporti economici, hanno cioè una vita psichica che deve essere tenuta presente per spiegare l'andamento della storia. Per Horkheimer, se non si facesse riferimento alla vita psichica degli individui non si sarebbe in grado di capire perché gli individui vengono integrati all'interno di determinati contesti sociali e socio-politici nonostante le contraddizioni che caratterizzano questi stessi contesti, perché gli individui accettino determinate autorità sociali, addirittura un'intera gerarchia sociale; non saremmo in grado di comprendere nemmeno il motivo per cui gli individui accettano e sottoscrivono decisioni dei gruppi dominanti, delle classi dirigenti, che, come nel caso delle guerre, li danneggiano gravemente.
Come si articola l'utilizzazione della psicoanalisi da parte di Horkheimer e degli altri esponenti della scuola di Francoforte? Horkheimer si rifà alla distinzione freudiana fra "impulsi non differibili" - la fame la sete e così via -, cioè gli impulsi legati alla stessa conservazione fisica dell'individuo, e "impulsi differibili", gli impulsi sessuali o libidici in senso lato. Gli uomini, dice Horkheimer, non sono determinati solo dal loro immediato spirito di conservazione, ma anche dalla necessità di estroiettare le loro energie libidiche. Gli uomini hanno bisogno che la loro personalità sia riconosciuta e confermata all'interno di una collettività, hanno bisogno di sicurezza. Dunque lo sforzo di Horkheimer si orienta verso l'individuazione dei complessi rapporti fra "impulsi non differibili" e "impulsi differibili", fra vita materiale e vita psichica, in modo da mettere in evidenza come queste connessioni possano spiegare la relativa stabilità di un ordinamento sociale estremamente contraddittorio e lacerato da gravissimi contrasti interni.
6. Altri esponenti della scuola di Francoforte, oltre Horkheimer, si impegnarono nel tentativo di utilizzare la psicoanalisi ai fini dell'indagine sociale, in primo luogo ad Erich Fromm. Pensa che il tentativo di Fromm di coniugare psicologia del profondo e marxismo, abbia avuto più successo?
Erich Fromm era uno psicanalista di professione, era membro dell'Istituto psicoanalitico di Francoforte. Il suo progetto di coniugare psicoanalisi e marxismo è particolarmente significativo, intenso e complesso ma, al tempo stesso, destinato a incontrare ostacoli insormontabili. Nonostante lo sforzo di utilizzare la psicoanalisi ai fini dell'indagine e della ricerca sociale, Fromm non poteva accettare un punto importante della riflessione freudiana, e cioè la tesi espressa da Freud negli anni della Prima guerra mondiale, secondo cui nell'uomo, accanto alle pulsioni erotiche, si trovano anche le pulsioni distruttive: Eros e Thanatos venivano a costituire entrambi la struttura pulsionale dell'uomo. Fromm non poteva accettare questa tesi freudiana perché essa metteva in dubbio, in crisi, l'idea, che risaliva a Marx e al marxismo, di una "palingenesi sociale", l'idea che bastasse abolire la proprietà privata per far sorgere una comunità di liberi e di uguali. Questa comunità era idealmente caratterizzata da legami di solidarietà, di amore e raffigurava quindi una società come comunità nel senso pieno del termine. È ben noto che Freud aveva liquidato questo ideale marxista di una società completamente solidale, caratterizzata da legami di amore, realizzabile sulla base della soppressione della proprietà privata. A questo proposito, poiché è un punto molto importante per i pensatori della scuola di Francoforte, nel senso che ne costituisce un obiettivo polemico, vale la pena di leggere un passo del Disagio della civiltà di Freud. Questi scriveva: "non è affar mio la critica economica del sistema comunista, non posso sapere se l'abolizione della proprietà privata sia opportuna e proficua, ma sono in grado di riconoscere che la sua premessa psicologica è un'illusione priva di fondamento; con l'abolizione della proprietà privata si toglie al desiderio umano di aggressione uno dei suoi strumenti, certamente uno strumento forte, ma altrettanto certamente non il più forte". Poco prima aveva affermato che "la verità negata con tanto zelo è che l'uomo non è una creatura mansueta, bisognosa d'amore, capace al massimo di difendersi se viene attaccata, ma che occorre attribuire al suo corredo pulsionale anche una buona dose di aggressività". Ne consegue, secondo Freud, che l'uomo vede nel prossimo non soltanto un eventuale aiuto e oggetto sessuale, ma anche un bersaglio per sfogare la propria aggressività; può tendere a sfruttarne la forza lavorativa senza ricompensarlo, ad abusarne sensualmente, a sostituirsi a lui nel possesso dei suoi beni, ad umiliarlo, a farlo soffrire, a torturarlo e a ucciderlo: "homo homini lupus"; chi ha il coraggio di contestare questa affermazione dopo tutte le esperienze della vita e della storia?
Naturalmente queste affermazioni di Freud non potevano piacere a Fromm e agli esponenti della scuola di Francoforte; si registra quindi una gravissima divaricazione di prospettive fra la scuola di Francoforte e le tesi del fondatore della psicoanalisi. Quello che i francofortesi non possono accettare è quest'idea di una ostilità primaria esistente nell'uomo, in quanto essa mette in discussione per l'appunto l'ideale di una grande palingenesi sociale e la possibilità di far sorgere quella che i marxisti chiamavano una società armonica e completamente unificata.
7. Professor Bedeschi, qual è stato il contributo di Theodor Wiesengrund Adorno alla ricerca della scuola di Francoforte?
Adorno è una personalità molto interessante ed estremamente complessa, come complessa anche la sua formazione culturale. Era nato a Francoforte nel 1903; il cognome di suo padre era Wiesengrund, il cognome Adorno era quello della madre; egli assunse quest'ultimo e relegò il cognome del padre a secondo nome. Questo lascia pensare che sul piano della vita psicologica Adorno avesse dei problemi con la figura paterna. Ciò si può affermare dato l'interesse che questi studiosi avevano per la psicoanalisi. Riguardo alla sua formazione culturale, Adorno aveva studiato a fondo musica e musicologia, si era trasferito a Vienna, nella Vienna di Schönberg, e aveva studiato lì alcuni anni. Aveva fatto anche approfonditi studi di filosofia, in particolare aveva studiato Kant e Hegel; altro particolare di interesse è il fatto che non si era rivolto solo al grande pensiero idealistico tedesco e al marxismo, ma aveva studiato anche i grandi pensatori "irrazionalisti", Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. Gli interessi di Adorno sono sempre stati vastissimi, e la sua opera spazia dalla critica letteraria alla musica, dalla sociologia alla filosofia, alla storia della civiltà. Non ha mai scritto opere sistematiche; ha sempre preferito la formula del saggio breve, dell'articolo, dell'aforisma. La sua scelta di non scrivere grandi opere risponde ad una convinzione profonda, che egli ha espresso, tra l'altro, nel 1931 quando dichiarò: "chi oggi sceglie il lavoro filosofico come professione, deve rinunciare all'illusione con la quale prendevano precedentemente l'avvio i progetti filosofici, che sia possibile afferrare in forza del pensiero la totalità del reale".
Adorno era convinto che nel mondo moderno questa totalità del reale fosse andata distrutta, frantumata, che il mondo sociale moderno fosse qualcosa di così contraddittorio e lacerato da rendere priva di senso l'aspirazione o la pretesa di rappresentarlo nella sua totalità. In questo senso è significativa l'opera che Adorno scrisse in collaborazione con Horkheimer negli anni fra il '42 e il '44, Dialettica dell'Illuminismo, che fu poi pubblicato subito dopo la guerra, nel 1947 ad Amsterdam. Se si tiene presente lo stile di questo libro molto denso di metafore e di paradossi, si può dire che il contributo di Adorno alla stesura del libro è stato decisivo, forse preponderante rispetto a quello fornito da Horkheimer. Il tema che è al centro di questa celebre opera è l'autodistruzione dell'Illuminismo: la convinzione dell'uomo di poter dominare la natura si tramuta nel proprio contrario. L'uomo in realtà è sempre più asservito da poteri che lo sovrastano e che egli non può controllare.
8. Quali sono i temi fondamentali della Dialettica dell'Illuminismo?
Leggiamo un breve passo dalla Dialettica dell'Illuminismo che spiega il senso dell'Illuminsimo e mostra inoltre il tipico stile letterario di Adorno: "L'illuminismo nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso, ha perseguito da sempre l'obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni, ma la terra interamente illuminata splende all'insegna di una trionfale sventura, gli uomini pagano l'accrescimento del loro potere con l'estraniazione da ciò su cui lo esercitano. L'Illuminismo si rapporta alle cose come il dittatore agli uomini, che conosce in quanto è in grado di manipolarli. Ogni tentativo di spezzare la costrizione naturale spezzando la natura, cade tanto più profondamente nella coazione naturale: è questo il corso della civiltà europea". Si deve sottolineare che l'Illuminismo non denota più una particolare epoca storico-politico-culturale. Adorno e Horkheimer con il termine "Illuminismo" intendono un particolare atteggiamento: la tendenza dell'uomo a dominare e a trasformare la natura in base ai propri fini e bisogni. Senonché questo tentativo non può non fallire e non rovesciarsi nel suo contrario, e cioè appunto nell'infelicità dell'uomo e nel dominio dell'uomo sull'uomo. Adorno e Horkheimer fuoriescono dal quadro categoriale del marxismo ortodosso, perché introducono un punto di vista radicalmente pessimistico sulla civiltà europea e non credono più al mito del progresso; questa visione pessimistica del corso della storia del mondo è congiunta all'aspra critica nei confronti della scienza e della tecnica.
Il grande avversario per Adorno e Horkheimer, è proprio la scienza, sia nella sua dimensione teorica che nella sua dimensione tecnico-pratica. C'è un passo importante della Dialettica dell'Illuminismo essi polemizzano duramente con Bacone: "Benché alieno dalla matematica, Bacone ha saputo cogliere esattamente l'animus della scienza successiva. Il felice connubio a cui egli pensa fra l'intelletto umano e la natura delle cose è di tipo patriarcale; L'intelletto che vince la superstizione deve comandare alla natura disincantata, il sapere che è potere non conosce limiti né nell'asservimento delle creature né nella sua docile acquiescenza ai signori del mondo [...] i re non dispongono della tecnica più direttamente di quanto ne dispongono i mercanti, essa è democratica come il sistema economico in cui si sviluppa: la tecnica è l'essenza di questo sapere". Ecco dunque il grande imputato per Adorno e Horkheimer: la tecnica e quello che la tecnica presuppone ovvero la scienza, un tipo di sapere che mentre si applica alla natura e vuole scoprirne le leggi, tende poi a trasformare la natura stessa, provocando un vero e proprio disastro per l'uomo e per la sua condizione nel mondo.
9. Professor Bedeschi, buona parte dell'opera di Adorno è dedicata all'analisi critica della "industria culturale"; questa è una categoria divenuta famosa a partire dagli anni '60, quando esplose un particolare interesse per la scuola di Francoforte. Quali sono allora i temi principali di questa critica che Adorno rivolge all'"industria culturale"?
Questo tema ha effettivamente avuto larghissima diffusione negli anni '60 ma anche dopo il '68. La critica dell'"industria culturale" è stata elaborata da Adorno, il quale dedica ad essa una parte cospicua della sua opera. Egli svolge un'analisi sociologica che è al tempo stesso un'aspra critica dei mass media, dei mezzi di comunicazione di massa: cinema, radio, pubblicità, televisione, rotocalchi e così via. Qual è l'idea fondamentale che muove Adorno in questa critica? È l'idea che i mezzi di comunicazione di massa fanno introiettare all'individuo il sistema esistente, i valori - o i disvalori, dal punto di vista di Adorno - del mondo e della società esistenti. Al fondo di questa critica c'è un presupposto ben preciso, il quale è comunque ampiamente discutibile: i mass media non sono qualcosa di neutro, i mezzi di comunicazione di massa non sono meri contenitori che possono essere riempiti con i contenuti più vari. In realtà per Adorno i mezzi di comunicazione di massa, i mass media sono essi stessi "ideologia", in quanto il loro compito precipuo è quello di diffondere un'immagine del mondo che sia accettabile da tutti, di sviluppare linguaggi uniformi e standardizzati che vadano bene per tutti; questo, a giudizio di Adorno, inevitabilmente contribuisce a determinare un conformismo generale.
I mezzi di comunicazione di massa dunque tendono a integrare l'individuo nella società esistente o, per utilizzare il linguaggio tipico degli esponenti della scuola di Francoforte, tendono a integrarlo nel sistema di dominio esistente. Da qui deriva l'attenzione che Adorno, mediante importanti saggi di analisi sociologica, ha dedicato, ad esempio, alla pubblicità: in essa ha visto il tipico strumento di manipolazione delle coscienze. La pubblicità sembra qualcosa di innocente, ma in realtà è uno strumento "diabolico" finalizzato a manipolare la coscienza individuale, a trasformare gli uomini in robot, in manichini, in qualcosa che possa servire agli scopi del sistema sociale dominante.
Bisogna tenere presente a questo proposito un dato storico-biografico importante e cioè che quando Adorno ed altri esponenti della scuola sviluppano queste tematiche, vivono negli Stati Uniti. Erano naturalmente tutti antifascisti, ed essendo inoltre tutti di origine israelitica all'avvento del Nazismo in Germania dovettero abbandonare il loro paese. Lo stesso Istituto per la Ricerca Sociale fu trasferito a New York e ospitato alla Columbia University. Negli Stati Uniti gli esponenti della scuola di Francoforte vengono a contatto con le caratteristiche e le tecniche della società industriale più avanzata, e queste caratteristiche divengono il principale oggetto di critica e di indagine.
Abstract
Bedeschi ricostruisce la nascita della scuola di Francoforte. L'Istituto per la Ricerca Sociale fondato a Francoforte nel 1922 è il primo Istituto accademico tedesco composto da intellettuali marxisti. Quando Karl Grünberg fu nominato direttore, "L'Archivio per la storia del movimento socialista e operaio", da lui fondato, divenne l'organo scientifico dell'Istitituto. Nel 1920 gli successe Max Horkheimer, sotto la cui direzione l'Istituto assunse quelle caratteristiche culturali che siamo soliti attribuire alla scuola di Francoforte . Dopo aver descritto la personalità di Horkheimer e la sua formazione intellettuale , Bedeschi introduce il tema della concezione dialettica del marxismo e delle scienze sociali condivisa dagli esponenti della scuola di Francoforte. Tale concezione implicava una dura critica del metodo scientifico, perché incapace di dare conto della realtà sociale come realtà dinamica, contraddittoria e "convulsiva". A differenza di Marx, per il quale la scienza e la tecnica erano considerate assolutamente indispensabili per il progresso ed essenzialmente neutre, gli esponenti della scuola di Francoforte, seguendo in ciò il punto di vista di György Lukács, negano che la scienza sia neutra. Al contrario, essa è inevitabilmente dominio, un dominio che si rovescia nel suo contrario, rendendo l'uomo schiavo di poteri incontrollabili. A differenza del marxismo classico, inoltre, i rappresentanti della scuola di Francoforte non credono nel progresso. Bedeschi spiega il tentativo operato da Horkheimer di integrare il marxismo con la psicoanalisi. La psicoanalisi è importante come scienza sussidiaria per intendere il processo storico, perché se è vero che gli individui sono all'interno di determinati rapporti economici, gli stessi individui vivono psicologicamente questi rappporti economici e la vita psichica che deve perciò essere tenuta presente per spiegare l'andamento della storia. Horkheimer utilizzando la distinzione freudiana tra impulsi legati alla conservazione fisica dell'individuo e "impulsi differibili", come gli impulsi libidici, ritiene che solo cogliendo i complessi rapporti tra questi diversi, quindi tra vita materiale e vita psichica, sia possibile spiegare la relativa stabilità di un ordinamento sociale. Anche Erich Fromm tenta di utilizzare la psicoanalisi ai fini dell'indagine sociale. Fromm, in particolare, non accettava la tesi freudiana secondo cui nell'uomo convivono pulsioni erotiche e pulsioni distruttive, vale a dire l'idea della presenza di un'insopprimibile ostilità primaria nell'uomo, perchè tale tesi metterebbe in crisi l'idea di Marx di una "palingenesi sociale". Bedeschi passa quindi a parlare di Adorno, dei suoi studi e della sua opera più conosciuta, scritta insieme a Horkheimer, Dialettica dell'Illuminismo, pubblicata nel 1947. Al centro dell'opera è il tema dell'autodistruzione dell'illuminismo, dove per illuminismo si deve intendere non un periodo storico, ma un atteggiamento: l'atteggiamento di manipolazione e di dominio della natura. Gli autori esprimono un radicale pessimismo nei confronti della civiltà europea; non credono nel mito del progresso e criticano la scienza e la tecnica. Bedeschi spiega perché Adorno considerasse l'"industria culturale" come una forma di ideologia finalizzata ad integrare l'individuo nel sistema di dominio esistente e le sue sottili analisi sulla pubblicità, considerata lo strumento tipico di manipolazione delle coscienze .
Da: http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste.asp?d=343#1#1